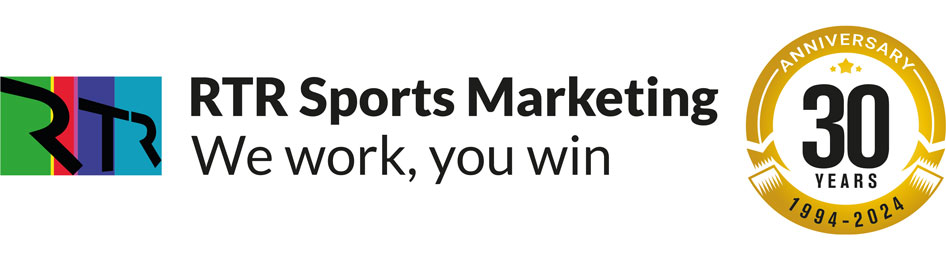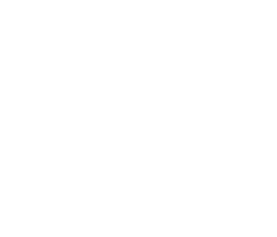Recentemente, il network televisivo a pagamento Sky ha fatto un grande regalo a tutti gli appassionati di pallacanestro d’oltreoceano: sul canale 205 della piattaforma si trova ora il canale Sky Sport NBA. Per l’immensa ed incontenibile gioia di mogli, fidanzate e compagne sparse in tutta la penisola, gli amanti della palla a spicchio più famosa del mondo possono ora seguire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 repliche, approfondimenti, partite storiche e analisi della National BasketBall Association.
Nelle infinite abbuffate di schiacciate, assist ed incredibili rimonte, tuttavia, un claim risuona più di insistente di tutti i richiami. È da molti anni il marchio di fabbrica del marketing NBA, comparso in una quantità di spot, transizioni e materiali di comunicazione. È la frase con cui la Lega forse più famosa al mondo si presenta a tutti i suoi ascoltatori: This is Why We Play.
This is why we play
“This is why we play” non è sempre stato lo slogan della NBA. Molte frasi ad effetto hanno accompagnato la lega ora capitanata da Adam Silver, da “where amazing happens” a “I love this game” sino al “NBA Action, it’s fantastic!” di lontana memoria.
È facile capire che a livello di comunicazione e marketing siamo davanti ad un salto importante. Eliminando per un attimo dal novero delle analisi lo slogan “NBA Action, it’s fantastic!” (talmente anni’80 e fluorescente da potere essere inserito senza grossi scrupoli in una puntata di Willy il Principe di Bel Air), sia “where amazing happens” che lo storico “I love this game” parlavano ad uno stesso pubblico, sebbene con una lingua diversa. Erano due slogan che, pur in modi molto diversi, raccontavano del piacere di guardare il basket e dell’emozione che si riceveva in cambio. Guardate le nostre partite, succederà qualcosa di incredibile, suggeriva la Lega, che solo qualche anno prima metteva in bocca allo stesso fan le parole “io amo questo gioco”.
Perchè “this is why we play è diverso”? Dove sta il salto?
In primis, come è facile capire, cambia il pronome e “io” diventa “noi”: è più inclusivo, più collettivo. Non c’è più lo spettatore solitario, chiuso dentro la sua stanza, a guardare le spettacolari gesta dei grandi campioni, ma ci siamo noi, il popolo del basket, una collettività e -più importante ancora- una community. Community su cui insistere particolarmente, poiché è qui, come insegna il marketing, che sta il grande valore nascosto di ogni campagna di comunicazione.
E tuttavia la grande rivoluzione non è qui, nel pronome, ma nella sua associazione con il verbo play: siamo noi a giocare. È un balzo concettuale e narrativo molto importante: d’un tratto il focus della campagna si sposta su uno spettatore/attore non solo presente, ma assai attivo.
Come hanno sostenuto molti commentatori, c’è un importante gap cognitivo da colmare: cosa c’è nel vuoto fra “io amo (guardare) questo sport” e “ecco perché noi giochiamo”? C’è un tentativo di equiparazione, una voglia di mettere tutti sullo stesso piano? È un tentativo di inclusione che tira verso l’alto, equiparando gli spettatori alle superstar o un prudente messaggio di segno opposto della governance del basket che smorza i toni su atleti lautamente pagati e spesso alla mercé di rotocalchi e cronaca scandalistica?
In termini di marketing ci sono, probabilmente, altre ragioni. Per capirle bisogna fare un passo indietro, e tornare ad un concetto base dello sports marketing: chi è il consumatore di sport.
Il consumatore di sport fra spettatore e partecipante
È difficile mettere un etichetta precisa al consumatore di sport, poiché lo stesso concetto di prodotto sportivo è ampio e difforme. È un consumatore di sport chi si abbona allo stadio, chi compra su un canale pay per view una gara di Formula 1, chi acquista un oggetto di merchandising o chi acquista una scarpa per la palestra. D’altro canto, è un consumatore di sport anche chi si iscrive ad una maratona, chi affitta un campo per giocare a calcetto con gli amici, o chi la domenica si reca sulle piste per una bella sciata. Queste figure, così apparentemente diverse, sono tutte consumatrici di sport, proprio perché interagiscono con prodotti sportivi, seppure assai diversi.
È evidente che non è possibile lavorare con categorie così vaste e eterogenee: occorre iniziare a fare una distinzione. Il più celebre ordinamento strutturato del consumatore di sport arriva attorno alla metà degli anni ’90 (Milne, Sutton, & McDonald, 1996) e suddivide definitivamente il pubblico dello sport in due macro-categorie:
- Il Consumatore Spettatore
- Il Consumatore Partecipante, o praticante
Sebbene la distinzione fra i due gruppi sia evidente fin per un bambino, la costruzione teorica regge ancora oggi fra gli studiosi di sports marketing, che la utilizzano come punto di partenza per varie teorizzazioni sulle motivazioni al consumo stesso dello sport (Milne et al., 1996; Lascu et al., 1995; Sloan, 1985; Stone, 1971; Zillmann et al., 1979) e dei suoi corollari.
Uno dei principali punti di interesse della dottrina sono infatti le relazioni che esistono fra questi due diversi consumatori (Lascu, Giese, Toolan, Guehring, & Mercer, 1995; Shank & Beasley, 1998; Sloan, 1985; Zillmann, Bryant, & Sapolsky, 1979): sono tipi di persone completamente diverse e mosse da motivazioni differenti o sono invece queste definizioni molto “liquide”, con grandi aree di sovrapposizione?
Una delle letture più interessanti sulla faccenda, senza scendere nei meandri di una letteratura davvero sconfinata, viene offerta quando si iniziano ad esaminare insieme non solo i tipi di spettatore, ma i tipi di spettatore in base ai tipi di sport. La gaussiana che risulta dall’incrocio di questi due elementi apre un terreno d’inchiesta tanto semplice quanto sorprendente e rapidamente divenuto lo starting point per le azioni di qualunque squadra sportiva.
Spettatori e partecipanti: cosa facciamo noi davvero con lo sport
Uscendo un istante dal seminato teorico, vediamo in maniera schematica come si incrociano nella pratica le due categorie di consumatore descritti in precedenza, partecipante e spettatore, in determinati tipologie di sport facendo riferimento al grafico qui sotto, dove le parti in rosa sono gli spettatori, e quelle in giallo i partecipanti (ed ovviamente, quelle in arancione la sovrapposizione delle due situazioni).
 Prendiamo uno sport come la pallacanestro. L’insieme dei praticanti è più piccolo degli spettatori, e quasi interamente contenuto nel diagramma più grande. Chi pratica la pallacanestro, infatti, quasi sempre ne è anche spettatore, anche se non è vero il contrario. La medesima situazione si amplifica ulteriormente nel calcio, uno sport con una audience sconfinata, in cui quasi ogni partecipante è anche spettatore (a memoria, è impossibile trovare un calciatore che non guardi almeno una partita ogni tanto).
Prendiamo uno sport come la pallacanestro. L’insieme dei praticanti è più piccolo degli spettatori, e quasi interamente contenuto nel diagramma più grande. Chi pratica la pallacanestro, infatti, quasi sempre ne è anche spettatore, anche se non è vero il contrario. La medesima situazione si amplifica ulteriormente nel calcio, uno sport con una audience sconfinata, in cui quasi ogni partecipante è anche spettatore (a memoria, è impossibile trovare un calciatore che non guardi almeno una partita ogni tanto).
Ci sono poi situazioni molto equilibrate, come il golf o il tennis in cui è ravvisabile un eccellente equilibrio tra praticanti e spettatori e una discreta, anche se non amplissima sovrapposizione. Non a caso, tennis e golf sono -per quanto possa non sembrare- discipline assai simili come target e come demografiche sociali dei consumatori. Sono sport eleganti, costosi, che si giocano principalmente da soli e all’interno di club.
Infine, vi sono situazioni assolutamente estreme, come la Formula 1 o il running.
Partendo dalla prima basti dire che la F1 (il secondo sport più visto in Italia e uno dei più amati dell’intero pianeta) conta solo 22 piloti, a fronte di decine di milioni di spettatori. Per quello che riguarda il running, vale l’estremo opposto. In un mondo in cui tutti o quasi tutti un giorno hanno detto “oggi vado a farmi una corsa”, pochissimi guardano maratone o eventi di podismo.
Spettatori e partecipanti: cosa fanno le properties con lo sport
Se quanto detto sino a qui può essere interessante per tifosi e praticanti (ed è un’analisi curiosa: io guardo il calcio ma non lo pratico, vado a correre ma mai mi sognerei di guardare una maratona, amo la Formula 1 ma ovviamente mi limito al divano), il gioco è ancora più importante per le aziende e i brand dello sport.
Come in un grande Risiko, i proprietari di prodotti sportivi hanno rapidamente capito che l’espansione e il successo del loro business dipende dalla conquista di quelle parti del grafico di colore opposto al loro.
Più che conquistare nuovo pubblico, evangelizzandolo da zero, si preferisce partire all’attacco dei consumatori di quello sport che ancora non rientrano nel nostro cerchio. Questo ovviamente a seconda del fatto che le aziende/brand produttrici vendano/offrano prodotti per spettatori (NBA, Manchester United, Dorna, Wimbledon per citare alcuni nomi) o per partecipanti (Nike, Under Armour, la palestra sotto casa, le biciclette Bianchi…)
Facciamo un esempio molto concreto per spiegare questi concetti.
Io sono un grande amante dell’automobilismo sportivo. Uno sport con larghissimo seguito ma pochissimi praticanti, per ragioni fra le più disparate: è abbastanza costoso, scomodo da praticare, richiede molto know-how tecnico e necessita di importanti infrastrutture sul territorio. In tal senso, le aziende che producono prodotti per consumatori spettatori di automobilismo sportivo fanno con me affari d’oro: canali TV, merchandising, prodotti in licenza e videogiochi riempiono la mia lista dei desideri e vuotano il mio portafogli. Io sono nel cerchio rosa, per usare i colori che sono nel grafico qui sopra, e tutti i brand che producono nel cerchio rosa sono -con me- assai felici. Eppure non pratico automobilismo sportivo (cerchio giallo) e tutti i brand che producono per quell’area (produttori di pneumatici da gara, tute e caschi da automobile, ricambi e spare parts) da me non vedono un euro. Quale è il loro obiettivo? Andare nella zona rosa, a cercare nuovi consumatori. Come faranno? Facendo attività e comunicazione di incentive (corsi di guida, prove in pista, test drive) sul pubblico di consumatori-spettatori.
Come è facile capire, cercare di convertire in praticanti quelli che sono spettatori e in spettatori quelli che sono praticanti è azione ben più semplice di portare consumatori totalmente nuovi all’interno del grafico. Io non amo, ad esempio, gli sport a cavallo: non li guardo e non li pratico. Per una qualsiasi azienda del settore dell’equitazione cercare di portarmi a bordo come consumatore spettatore o come consumatore praticante richiederebbe un ingente dispendio di energie economiche e di marketing, peraltro con risultati dubbi. Con grande probabilità continuerei a disinteressarmi di tutto ciò che riguarda l’equitazione.
È interessante notare come questo movimento verso la parte opposta del grafico avvenga in entrambe le direzioni contemporaneamente, ma con un unico denominatore comune: l’inclusione.
If you have a body, you are an athlete
Basta guardarsi attorno per comprendere come tutti coloro che creano prodotti sportivi in senso lato, stiano adottando politiche comunicative e di marketing sempre più virate alla inclusione. È sufficiente vedere cosa i grandi club del calcio europeo stanno facendo a livello grassroot o pensare a come Nike e gli altri grandi brand di sportswear stiano cercando di equiparare il runner occasionale al grande atleta per comprendere questo tentativo di sovrapporre spettatori e praticanti. “If you have a body, you are an athlete” recita la grande scritta all’interno del Nike Store di molte città del mondo, chiudendo definitivamente il cerchio su quanto si è detto fino a qui.
Cercare di convincere un tifoso alla pratica dello sport, e, d’altro canto, convincere un convinto praticante a diventare un accanito spettatore è una delle chiavi del marketing sportivo moderno. Un marketing dove nessuno o quasi cerca più di tirare a sé consumatori disinteressati o esterni al nostro diagramma a cerchi.
Prende ora sostanza diversa la frase “This is why we play” di cui si parlava in apertura. Con essa, la NBA parla a tutti i praticanti del basket mondiale cercando di farli diventare consumatori spettatori. Il messaggio, parafrasato, è “se giocate a pallacanestro, allora dentro i nostri programmi e il nostro mondo c’è l’eccellenza del gioco stesso, la ragione stessa per cui il gioco esiste”. Voi diventa noi. Non vi chiediamo di guardare, vi diciamo di giocare tutti insieme.
È un’inclusione forte e omnidirezionale: non ci sono geografie, differenze sociali o di classe e -sopratutto- livelli di bravura o di talento. Quello che la NBA sta facendo, per tornare al grafico, è non spingere i confini del proprio cerchio, ma tirare i confini del cerchio giallo affianco, con l’obiettivo di renderli totalmente sovrapposti.
Possibile, si dirà in ultima analisi, che un simile pandemonio di nozioni, concetti, teorie e scrupoli didattici sia davvero racchiuso in 5 parole? Ed altresì, è possibile che il pubblico comprenda o quantomeno intuisca un simile ragionamento e modifichi (come è auspicio di tutti i brand del mondo) il suo comportamento?
La risposta è di Schroedingeriana memoria ed è contemporaneamente Sì e No. Come tutti i grandi processi comunicativi, come tutte le grandi transizioni dello sports marketing ma del marketing in generale, anche questi passaggi esistono e funzionano solo se inseriti in un contesto olistico, uniforme e coerente. Il passaggio fra i due tipo di consumatore e le politiche di inclusione non passano per una frase, ma per un sistema di azioni: dalla comunicazione alla creazione e gestione di fan-zone, dalla gestione del merchandising alle politiche di ticketing, dalle attivazioni online e offline alla goodwill, tutto conta.
Non si vuole qui cercare di convincere il lettore che dentro cinque parole possano stare 25 anni di teoria di comunicazione sportiva. Al contrario, si vuole dire che quelle cinque parole sono proprio figlie di questo contorno teorico e sociale e che sono un segnale dei movimenti in atto. Piccoli, lenti e composti da un microcosmo di elementi, ma presenti: una specie di tettonica delle placche del marketing sportivo.
Anche in questo sta la bellezza, e la poesia, di questo mondo.
Se volete approfondire il tema o avete curisoità specifiche non esitate a contattarci utilizzando info@rtrsports.com